Maratea
preistorica: i neandertaliani nelle grotte di Fiumicello
Quali sono stati i primi Uomini ad aver abitato sulla costa
di Maratea?
La domanda è molto interessante. La Storia propriamente
detta, infatti, inizia proprio con loro: la Storia di un territorio inizia
quando l’Uomo comincia ad abitarlo. I tempi precedenti al popolamento umano non
sono di competenza dello storico, bensì del geologo, che del territorio studia
la formazione e lo sviluppo.
Nota: questo scritto è la fedele
trasposizione di quattro pagine del primo capitolo della
Storia di Maratea compresa nel mio
progetto noto come Enciclopedia di
Maratea. Colgo l’occasione per assicurare che il progetto è in svolgimento
e vedrà la luce non appena gli impegni di vita e di lavoro mi permetteranno di
sbobinare completamente le quasi 50.000 (cinquantamila) pagine di documenti
d’archivio che ho raccolto negli ultimi 11 anni in
giro per l’Italia.
Il primo
popolamento umano.
La penisola italiana è abitata da esseri che possiamo qualificare Uomini da circa un milione di anni. Nel
territorio dell’attuale Basilicata il popolamento sembrerebbe iniziato
settecentomila anni fa.
La prima specie di Uomo ad aver popolato l’Europa pare sia stata l’Homo habilis, a cui è succeduto l’Homo erectus o ergaster, da cui poi hanno avuto origine i diversi tipi di Homo sapiens. Tutte queste specie vivono
nomadi, sono cacciatori e raccoglitori dei frutti spontanei. La loro vita è un continuo e ininterrotto migrare in terre dove si insediano
fin quando non ne consumano le risorse. I siti archeologici in cui lo studioso
trova le loro tracce, quindi, non vanno intesi come abitati o insediamenti
stabili, ma solo come le tappe temporanee del loro cammino senza fine.
Nel golfo di Policastro i siti preistorici più antichi sono quelli
di Cala Bianca e Cala Arconte, presso Marina di Camerota, e di Rosaneto, a Tortora, dove sono stati trovati reperti del
Paleolitico inferiore. Molti studiosi hanno ignorato che, negli
’70 del XX secolo, l’archeologo Pietro Colacicchi
(1937-2014), professore all’Università di Siena, scoprì che il sito tortorese
si espandeva da una sponda all’altra del fiume Noce e toccava quello che ora è
territorio di Maratea.
Nei pressi di Castrocucco, Colacicchi
trovò reperti di due culture preistoriche, l’Olduvaiano
(o Cultura del Ciottolo) e l’Acheuleano.
«L’Acheuleano
– scrive Colacicchi – è rappresentato da una ventina di
bifacciali, comprendenti alcuni esemplari lanceolati e micocchiani di fine
fattura e due hacereaux. La componente bifacciale è accompagnata da
elementi su scheggi e da nuclei di tecnica Levallois. […]
Nel complesso, l’Acheuleano di
Castrocucco, seppure quantitativamente più modesto, richiama esattamente quello
della riva sinistra del Noce, suggerendo la stessa attribuzione ad una fase
finale di questa cultura. Il complesso su ciottolo – continua
l’archeologo –, assai più cospicuo,
comprende circa 400 choppers, in marcata prevalenza a scheggiatura unifacciale e di tipo distale, meno frequentemente
appartenenti a tipi più complessi,
come i latero-distali, i doppi, i “periferici”, gli appuntiti, etc.
Accompagnano i choppers alcuni rozzi
raschiatoi e denticolati (relativamente poco numerosi), di solito su calotte di
ciottolo o schegge comunque a faccia dorsale in parte corticata».
Nonostante il poco risalto ricevuto, i ritrovamenti di
Castrocucco sono molto importanti: sono la più antica traccia della presenza
umana sul territorio di Maratea e tra le più antiche in quello della
Basilicata.
Reperti del Paleolitico inferiore sono piuttosto rari. Le
temporanee stazioni di questi Uomini nomadi, cacciatori e raccoglitori,
erano all’aria aperta, su terrazzamenti lungo il corso di fiumi, più rari
quelli in grotta. Ciò, ovviamente, non ha favorito la conservazione delle loro
tracce fino a noi.
I
Neandertaliani nelle grotte di Fiumicello.
Gli Uomini del Paleolitico medio hanno lasciato molte più
tracce sulle nostre terre. Durante quest’epoca si verifica
la glaciazione di Würm, che sconvolge tanto il clima
che il paesaggio d’Europa. Le coste del golfo di Policastro, ricche di grotte e
altre cavità, offrono comodo riparo agli Uomini di Neanderthal, un cui
scheletro è stato ritrovato nella grotta del Poggio a Marina di Camerota.
Reperti di quest’epoca sono molto diffusi: se ne sono trovati nella grotta di
Mezzanotte presso Sapri, nella grotta di Torre Nave a
Tortora, sull’isola di Dino e nella grotta di Torre Talao a Scalea.
Nel 1952, il paleontologo Vincenzo Fusco, professore
all’Università Governativa di Milano, decise di intraprendere delle ricerche
lungo la costa di Maratea, rimaste, all’epoca, tra le poche non ancora
studiate. Già in questo suo primo sopralluogo il prof.
Fusco individuò resti di fauna pleistocenica in una delle grotte presso la
spiaggia di Fiumicello. Deciso a fare più approfondite indagini, Fusco tornò a
Maratea con dei colleghi nel 1957. In questa nuova ricerca, scoprì che la
grotta era stata abitata durante il Paleolitico medio.
«Abbiamo potuto
raccogliere – annota Fusco per l’antro più prossimo alla spiaggia
–, alcune schegge di quarzite molto
rozze, con bulbi di percussione abbastanza evidenti, con piani di percussione
preparati, ampi, fortemente inclinati nel pezzo, con lavorazione
monofacciale molto semplice, senza alcun
ritocco periferico. Il complesso si presenta invero piuttosto povero, tuttavia
si può affermare trattarsi di industria musteriana
che, per i caratteri descritti, si direbbe di carattere più arcaico del
musteriano tipico. Tra i pochi rifiuti di lavorazione e pezzi atipici è
interessante notare la presenza di un grosso mezzo ciottolo di quarzite, dal
quale risulta staccata una scheggia. Tale rozza industria litica era accompagnata da un esiguo numero di
ossa, per lo più scheggiate nel senso della lunghezza e spezzettate, alcune
delle quali semicombuste e costituenti
presumibilmente avanzi di pasti».
Un altro reperto, un raschiatoio «di tecnica musteriana, di forma trapezoidale con fine ritocco lungo uno
dei lati maggiori», venne ritrovato nella grotta
più lontana dalla riva.
Certamente, anche altre grotte della costa di Maratea hanno
offerto rifugio agli Uomini di quest’epoca. Per la mancanza di ricerche
sistematiche, però, non possiamo sapere quali sono state le più frequentate.
Abbiamo notizia certa solo in un altro caso, la cavità di Sotto la Torre, ad Acquafredda,
dove negli anni ’90 del XX secolo vennero
accidentalmente ritrovati alcuni manufatti musteriani.
Il più
antico paesaggio marateota.
I reperti paleolitici, oltre a offrirci delle deboli luci
sulla vita degli Uomini dell’Età della Pietra, possono
essere usati anche per dedurre come poteva apparire quello che oggi è il nostro
territorio.
Per esempio, le grotte alla spiaggia di Fiumicello dovevano
apparire molto diversamente agli occhi degli Uomini del Paleolitico medio. Le
glaciazioni, come detto, non incidono soltanto sul clima, ma anche sul
paesaggio. Il raffreddamento della Terra è tale che il livello del mare, per
effetto delle grandi distese di ghiaccio, si abbassa di molti metri, facendo
emergere quella che oggi è parte della piattaforma marina. Le grotte a
Fiumicello, quindi, dovevano apparire come un rifugio comodissimo lungo la
linea di un terrazzamento aperto a monte della
costiera pleistocenica.
Al contrario, nei periodi interglaciali
(cioè i periodi più caldi tra un picco freddo e l’altro) la linea di costa
si alza al di sopra dell’attuale livello del mare,
perché lo scioglimento dei ghiacciai versa una grandissima quantità d’acqua in
mare.
Secondo uno studio basato su dati geologici, nel periodo
interstadiale caldo della glaciazione di Würm la
linea di battigia si trova tra 2 e 5 metri più in alto
del livello attuale, scesa poi, nel picco di freddo, a ben 100 metri al di
sotto. Per capirci, durante il massimo di freddo, quella che è oggi l’isola di
Santo Janni appare come un promontorio alto quanto l’odierna Punta Caina.
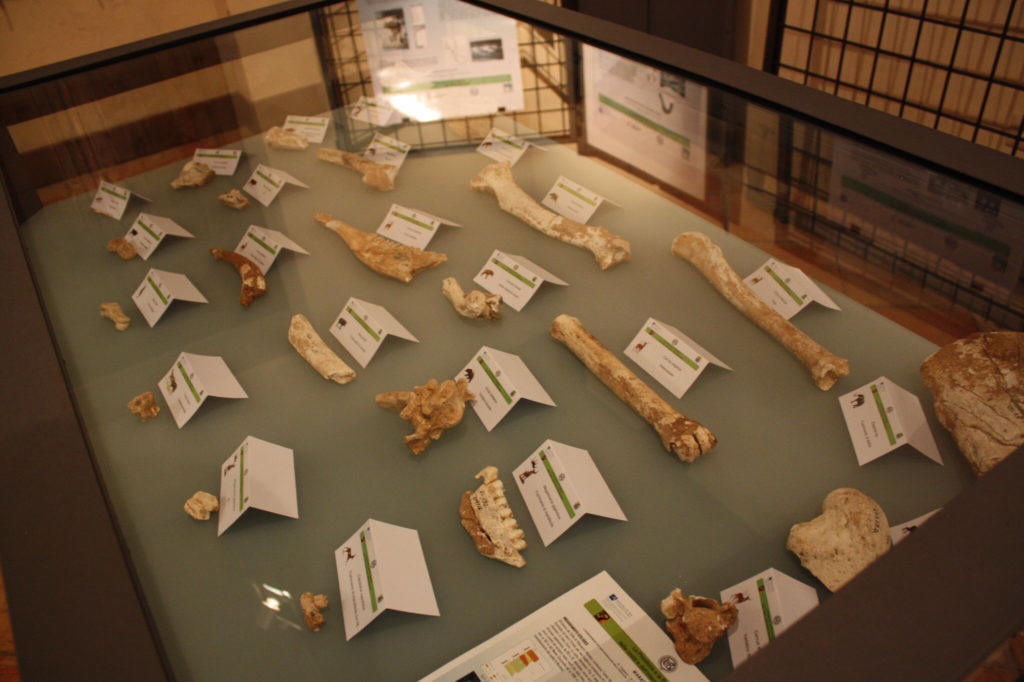
Le ossa
della Grotta Lina.
A diversi climi conseguono diverse
faune.
Tra il 1988 e il 1995, un gruppo di ricercatori delle
università La Sapienza di Roma e Federico II di Napoli
catalogò i reperti di un vasto giacimento di ossa animali scoperto nella Grotta
Lina, presso Marina di Maratea. Nel corso di migliaia di anni, in questa grotta
si sono ammucchiate le ossa degli animali che hanno popolato il territorio di
Maratea durante l’alternanza dei periodi glaciali e interglaciali. La loro
catalogazione ci permette di dedurre anche quello che poteva essere l’ambiente
floreale.
Al periodo più freddo risalgono i resti di orso delle caverne
(Ursus spelaeus),
stambecco alpino (Capra ibex), leone delle caverne (Panthera leo spelaea) e
lupo grigio (Canis lupus), i quali
suggeriscono un ambiente steppico. Nel graduale miglioramento climatico
resistevano esemplari di orso grigio (Ursus
arctos) cervo nobile (Cervus elaphus), cervo gigante (Megaloceros giganteus), capriolo (Capreolus capreolus), daino (Dama dama), volpe rossa (Vulpes vulpes),
cinghiale (Sus scrofa) e uro (Bos primigenius).
Con il graduale caldo alla steppa si sostituisce, probabilmente, una prateria
con qualche bosco termofilo (suggerito dai cervidi). Ai picchi di clima caldo
risalgono i reperti di leopardo (Panthera pardus), iena maculata (Crocuta crocuta) e non meglio identificati
rinocerontidi (genere Stephanorhinus).
Bibliografia.
Un amico, lettore attento, mi ha chiesto di aggiungere una
bibliografia nei miei articoli. Non sempre lo riterrò
necessario, ma per quanto riguarda questo articolo consiglio la lettura di: F. Mallegni, Il più
antico popolamento umano in Italia, in Italia
preistorica, a cura di M. Piperno & A. Guidi, Laterza 1992; V. Fusco, Stazioni del Paleolitico medio in grotte
costiere del golfo di Policastro, in «Rivista di Scienze Protostoriche»,
XVI (1961), pp. 6 ss.; Archeologia, arte
e storia alle sorgenti del Lao, a cura di P. Bottini, Matera, BMG, 1988; C.
Barbera, E. Billia, C. Petronio, A. Virgili, M.
Candeloro, F. Zarlenga, Short report on Pleistocene fauna from Grotta Lina (Marina di Maratea,
Southern Italy): paleological
and geochronological implications,
in «Bollettino della Società Paleontologica Italiana», 1995, n. 34 (3), pp.
341-350. Per la definizione dei paleoclimi
e paleoambienti, cfr. A. Tagliacozzo, I mammiferi dei giacimenti pre- e protostorici italiani. Un inquadramento paleontologico e archeozoologico,
in Italia preistorica cit., pp.
76-82.