Una donna
dimenticata: Cesira Fiori, una confinata a Maratea.
|
Luca Luongo |
Cesira Fiori è stata una intellettuale
e antifascista italiana, confinata a Maratea. Nella nostra cittadina la memoria
di ciò, così come del fatto stesso d’esser stata Maratea luogo di confino,
sembra essersi persa. Oggi, nella Giornata Internazionale della Donna,
riscopriamo questa donna dimenticata.
Chi era Cesira Fiori?
Nacque a Roma il 25 novembre 1890 da Massimo e da Giuliana
Mora Morunti. Nel 1908 iniziò la carriera di maestra
presso le scuole rurali statali di Velletri (RM).
Nel 1910 si iscrisse al Partito
Socialista Italiano. Prese parte alle manifestazioni contro la guerra di Libia
e contro l’intervento dell’Italia nella Grande Guerra. Aderì all’Associazione
donne italiane e si occupò dei problemi sindacali delle infermiere, delle
cucitrici, delle lavoranti a domicilio, battendosi per la pensione alle
casalinghe e per i diritti politici e civili delle donne.
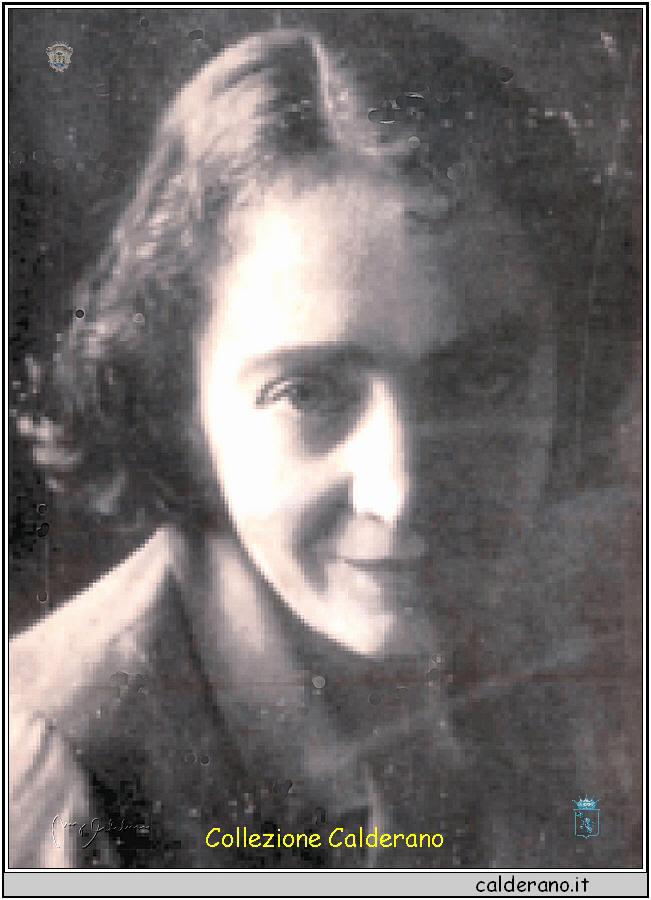 Nel 1921 fu tra le prime iscritte al Partito Comunista
Italiano.
Nel 1921 fu tra le prime iscritte al Partito Comunista
Italiano.
L’attività antifascista e l’arresto.
Con un curriculum del genere, non servì altro a Cesira per
attirare su di sé l’attenzione della polizia politica fascista. In più, il
Ventennio non fu un periodo facile per le lavoratrici italiane. Già nel 1926
iniziò l’esclusione delle donne dall’insegnamento superiore. La legge 221/1934
stabilì un limite del 10% della presenza femminile negli uffici pubblici e
privati.
Cesira, dal canto suo, non fu mai ambigua e contestò il regime sin dai suoi albori. Nel 1928 il governatore
di Roma la allontanò dalla scuola per incompatibilità politica. Il Consiglio di
Stato respinse il suo ricorso.
Si mantenne dando lezioni private. Parallelamente, con altri
antifascisti avviò delle azioni cospirative contro il regime. Essendo portata per
le Lettere, in particolare si impegnò nella pubblicazione de La Falce,
un foglio di propaganda clandestina destinato ai contadini. In più, aveva
attrezzato una sorta di biblioteca circolante per la diffusione di romanzi a
sfondo sociale.
Fu arrestata nel 1933 e destinata al confino politico nell’anno
successivo. Nel gennaio 1934 fu mandata a Ponza, dove sarebbe dovuta restare
per cinque anni. Ma, per ragioni di salute, nel settembre 1935 fu trasferita a
Maratea.
Una confinata a Maratea.
È ben noto il governo di Mussolini predilesse la Lucania come
destinazione dei confinati politici. Chi non conosce la vicenda di Carlo Levi
ad Aliano?
Ma i confinati non furono inviati
solo nei comuni interni. Anche Maratea fu sede di confino politico, sebbene la
storiografia locale lo abbia del tutto dimenticato.
Cesira Fiori arrivò a Maratea nel settembre 1935. Arrivò nel
nostro paese in treno. (Anche se la Fiori non ricorderà questo particolare
nelle sue memorie, per venire incontro alla sensibilità del lettore più nostalgico,
possiamo senza dubbio immaginare che il treno arrivò in perfetto orario.)
Il suo primo impatto con Maratea fu mediato dal capotreno.
All’approssimarsi alla nostra stazione, questi iniziò a ridacchiare. Quando
Cesira gli chiese il perché, lui le canticchiò: «Maratea, senza sole! /
tutte ‘e donne senz’onore! / se le corna fossero fraschi
/ Maratea ci avrebbe li boschi!». Per chi non li conoscesse, questi versi
sono di una canzoncina ottocentesca, in voga nei paesi dell’alto-tirreno
cosentino fino alla metà del secolo scorso, in cui si scherniscono tutti i
paesi della riviera.
«Chiedo scusa alla gentile, ospitale Maratea per questo
scherzoso detto che non le si addiceva certo -
scriverà poi Cesira in un libro di memorie - [Maratea è] un paese ospitale
e gentile, paese di sole donne, forti, cortesi lavoratrici (ci ho vissuto per
quattro anni circondata dalla stima e dall’affetto quasi unanime) e che mi
accolse con il lezzo dei suoi cedri, l’incanto verde della sua valle; dopo quel
rovente alito delle rocce affocate, arse, gialle, rossiccie,
brulle di Ustica, il profumo di quelle piante, il verde riposante della sua
mirifica valle, composero il primo balsamo che si soffuse sui miei nervi
straziati da tanto tempo».
A contatto con gli ultimi.
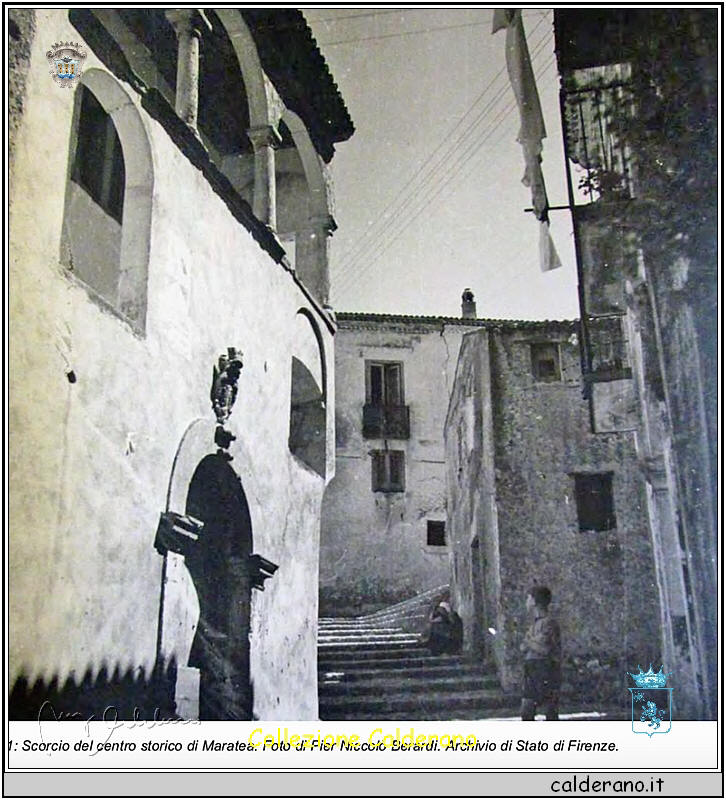 Cesira visse in via Pendinata prima
e in via Sotto le Monache poi. All’epoca, nei pressi della sua prima abitazione
si trovava la caserma dei Carabinieri. Gli uomini dell’Arma furono sempre
gentilissimi con lei e le diedero il libero usufrutto dei libri della biblioteca
della caserma.
Cesira visse in via Pendinata prima
e in via Sotto le Monache poi. All’epoca, nei pressi della sua prima abitazione
si trovava la caserma dei Carabinieri. Gli uomini dell’Arma furono sempre
gentilissimi con lei e le diedero il libero usufrutto dei libri della biblioteca
della caserma.
Ma soprattutto la Fiori fu vicina
agli ultimi, alle vedove e agli orfani dei figli degli emigranti che non si
facevano più vivi.
«Erano distribuzioni di dolcissimi
sguardi, tra segreti ascoltati e sorrisi senza risparmio. La gente si
avvicinava e ascoltava. Io naturalmente seminavo i più elementari principi
della nostra idea, [...] sulla miseria da eliminare, perché non si
deve mangiare tutta vita erbe cotte condite «co’ o pipe», o castagne secche
lessate, o i taralli duri di un mese ammollati nell’acqua, mentre pochi s’abbottano
di ciccia… molte teste si aprivano, sai? E continueranno ad aprirsi in mia
assenza, perché ho lavorato, io maestra, anche con gli studenti delle medie».
Dopo Maratea e le sue memorie.
Cesira Fiori lasciò Maratea nel maggio 1939. Nonostante la
pena di confino fosse giunta al termine nel 1938, fu trasferita a San Demetrio
ne’ Vestini (AQ).
Nel giugno 1944, ancor prima dell’arrivo delle truppe
Alleate, il Comitato di liberazione nazionale la
nominò sindaco di San Demetrio. Nell’ottobre dello stesso anno tornò a Roma.
Riprese l’insegnamento nelle scuole e organizzò il sindacato degli insegnanti.
Morì a Roma il 9 gennaio 1976.
Cesira pubblicò diversi volumi nel
periodo repubblicano. In due di questi, Una donna nelle carceri fasciste
(1965) e La confinata (1979), raccontò gli aneddoti della sua
esperienza a Maratea.
La memoria della sua permanenza è praticamente scomparsa nel
nostro paese, così come molti altri fatti del Ventennio. Nel 2011 la
pubblicazione postuma di Maratea nel panorama postunitario, ultimo
lavoro del prof. José M. Cernicchiaro (1949-2010), colmò molte lacune sul
periodo. Ma ci sono ancora molti vuoti da riempire, in particolare per quanto
riguarda i confinati politici. Un giorno, speriamo vicino, una ricerca nel
fondo dedicato all’Archivio di Stato di Potenza porterà alla luce altre storie
come quella di Cesira Fiori.